E mentre qualcuno di voi, magari, sta già pensando di acquistarlo… rileggo e… No, non è questa la mia recensione-analisi del libro: troppo semplice, troppo sbrigativa, troppo approssimativa…
Mi piace la protagonista: si chiama Violette Toussaint. L’autrice non ha scelto il nome a caso, ma con sottile attenzione per i due elementi focali dell’intera narrazione: i fiori (Violette) e il cimitero (Toussaint). Sì, perché l’inedita e originale location del libro è un cimitero, quello di Brancion-en-Chalon. È incredibile come le fini descrizioni riescano a proiettare magicamente il lettore tra le tombe di nomi ignoti e inventati, nella casetta di Violette, tra fiori, gatti, cani e vestiti d’inverno sopra vestiti d’estate (leggete, leggete, e capirete…); in punta di piedi e con la delicatezza di una scrittura decisa e semplice, gli occhi della mente vengono irretiti da un microcosmo fatto di iscrizioni funerarie, lacrime e sorrisi, ricordi e rimpianti, quaderni di appunti, dolore reale o presunto, precisazioni meteorologiche persino… Eppure, le parti più toccanti, quelle che si dischiudono sotto l’odore delle stagioni e del tempo passato e futuro, sono le confidenze di perfetti sconosciuti a Violette. Lei ascolta la voce tremante per la commozione di viandanti che errano tra gli stretti sentieri delle tombe, che portano un fiore o il carico di un amore sofferente e che si fermano nella sua casetta per raccontare e raccontarsi, nel silenzio delle pareti rosa (come la copertina… come i vestiti d’estate…), nell’aria mischiata di the, animali e persone, forse tabacco, ma solo di passaggio. Violette ascolta e chi le parla ha la consapevolezza che quei segreti, inconfessati e inconfessabili in normali circostanze, rimarranno là, nella casetta con il cancello verde scuro, dove Tempo e Spazio si inchinano dinanzi alla memoria del viandante. E tutto si ferma. La dimensione emozionale che ne scaturisce mi rassicura e mi disorienta. Sono coinvolta, ma non del tutto convinta. I personaggi (tanti) che si avvicendano nel percorso della storia sono descritti con tratti decisi, veloci. Ritratti fisici e psicologici hanno fretta di essere definiti, senza indugiare troppo sulla capacità di immaginazione e di immedesimazione del lettore. Eppure, nel crescendo delle pagine, spuntano nuovi dettagli e quelle caratterizzazioni – che sembravano quasi banali in alcuni casi – si ammantano di dettagli inattesi, come se una persona vicina e conosciuta si svelasse ai nostri occhi una seconda, terza, quarta volta, lasciandoci quantomeno perplessi davanti alla inedita rivelazione. Un caso emblematico – forse quello che preferisco dell’intero romanzo – è il marito di Violette, Philippe Toussaint. La sua storia, fatta di non-detti e di confessioni mancate, è quasi un affaire emotivo. La manifesta bellezza fisica lo porta a desiderare costantemente il proprio autocompiacimento. Lo osservo, con un latente sentimento di velata condanna morale, mentre viene sedotto da donne che non resistono al suo fascino, che gli si affiancano come cagnoline inermi e indignitose, o – forse peggio – come le femmes de mauvaise réputation* dell’indirizzo, ricettacolo di uomini e donne dai sentimenti ottenebrati e alla bestiale ricerca del mero appagamento sessuale. Philippe sembra quasi un clichè… fin qui… Il classico “bello e dannato”, la cui dannazione è indissolubilmente legata all’immagine dell’inarrestabile sete di sesso. Tocca il fondo con Geneviève Magnan, una delle sue amanti, che – ironia della sorte beffarda – tornerà nella sua vita a intervalli irregolari e con la pretesa di fare tristemente luce sulla vicenda personale più drammatica. La reificazione sessuale della donna, posseduta nello squallore di una roccia imbevuta di muschio e lacrime, ammanta Philippe di meschinità e provoca nel lettore un senso di fastidio e ripugnanza; fa sentire in bocca il sapore del muschio bagnato e del dolore di Geneviève, che – me ne accorgo ora – ha un’anima, sotto il grigiore della sua modesta esistenza, che appare priva di amore, tutta protesa ad una logica meccanicistica della sopravvivenza attraverso gli stenti. Ma l’epifania di Philippe Toussaint è lontana dalla consapevolezza del lettore. Si aggira guardingo e inquieto sulla sua moto, vicino a luoghi e persone conosciuti, amati segretamente o odiati palesemente. I suoi gesti sono freddi, distanti, dispettosi, rasentano la violenza, la toccano, urlano vendetta e lui sembra non averne alcun interesse, incallito narcisista, patologicamente egoista… Invece, la sua è senza dubbio la storia più triste del romanzo… Le emozioni prendono forma gradualmente e vengono rivelate attraverso un intrico cronologico costruito ad arte su feedback e rimandi ad anni diversi, che si inseguono, cavalcando un arco temporale che si dispiega tra il 1981 e il 2017. Ha amato anche lui, l’incallito narcisista, ha amato, ma di un amore inquieto, di quegli amori che restano sotto la sabbia per troppo tempo e finiscono per trasformarsi in acredine, in rancore, soprattutto in rimpianto. Alla fine del libro, la sua inquietudine ha assunto i tratti della disperazione. Valérie Perrin, però, ne evoca una remota redenzione nel suo improvviso sentimento di paternità, mai avvertito prima, che lo riconcilia, se non con se stesso, con sua figlia nel gesto estremo e definitivo con cui cala il sipario sulla sua definitiva uscita.
I luoghi del romanzo sono insoliti, male assortiti, allegorie di astratte sensazioni, che pervadono, come spiritelli impertinenti, anche il lettore, che non ha cuore di abbandonarli, nonostante la loro sinistra essenza. Eppure… Un passaggio a livello, una tomba, un cimitero senza fuochi fatui e senza nemmeno un fantasma, una casetta dal cancello verde scuro diventano straordinariamente familiari. L’autrice è riuscita a trasformarli in luoghi dell’anima, che, come ogni spazio fisico, ha poco senso se non è popolato dai sentimenti di coloro che lo abitano. Le storie del passato si annidano con vigore al petto di coloro che le confidano o le nascondono e personaggi dalle esistenze indipendenti e parallele si ritrovano nell’intercapedine di una tomba, sospese sulle lettere di una dedica funeraria e se ne scoprono gli intrecci e gli intrighi e si realizza che la morte è solo il fermo immagine di chi abbiamo amato. Ma le anime sono altrove. E se è vero che la morte non fa pause, è rassicurante sapere che la vita è fatta di stagioni. E di drammi. Quasi sempre. L’odore dei fiori e il colore dei pensieri si mescolano con le intime confidenze che i personaggi si scambiano, nelle loro vite apparentemente semplici, dove il desiderio di serenità si scontra, in un duello spesso impari, con il peso della sofferenza per i propri cari defunti. Sento il rimando – probabilmente fuorviante, sicuramente discutibile – con i fiori pascoliani, che si caricano di valenze sfumate, simboliche e soggettive e lo straordinario universo delle percezioni sensoriali diventa un passaporta che schiude il varco a immagini e analogie luttuose, in una corrispondenza tra vivi e morti che non s’interrompe mai. E così, le estati e gli inverni che Violette reca con i suoi vestiti rimangono intrappolate in un vortice di mancati fuochi fatui, dove sogno e realtà diventano monodimensionali, si rincorrono tra delusioni e speranze nel gioco, spesso perverso, delle loro esistenze interrotte. Dopotutto, Violette sembra l’unica “non-vinta” dai misteri del camposanto. Con dolorosa difficoltà, riesce a voltare pagina e a iniziare un nuovo capitolo, la cui parola d’ordine è sempre la stessa, l’amore. Senza mai dimenticare. Ovvio.
Credo che tutto il libro ruoti intorno all’amore, ma non quello edulcorato ed enfatico della scrittura leziosa o un tantino artefatta, memore ed erede dell’intimismo romantico. L’amore descritto tra le pagine di Perrin si avvicina straordinariamente all’amore reale, quello che non è possibile ricondurre ad univoci paradigmi di positività ed assolutezza… È un amore che si alimenta di rimpianti, di errori, di istinti e di scelte sbagliate. È un amore talmente forte che conduce i personaggi in un turbinio di emozioni antitetiche, alimentato dallo scorrere del Tempo, protagonista indiscusso, che domina e impaura, condanna e redime.
È un bel romanzo. Si legge tutto d’un fiato. Confermo. Era tanto che non trovavo questa sensazione nella lettura di romanzi contemporanei. Mi piace la lente di ingrandimento che l’autrice impugna con sicurezza quando deve rappresentare il mondo interiore delle sue creature. È a suo agio lungo i numerosi e sconnessi viottoli emotivi che apre tra i parallelismi narrativi e quando si arriva al crocevia, i finali si sovrappongono, onde poi dipanarsi in conclusioni differenti. Sospiro. Chiudo il libro. Stanotte devo pensare a tante cose. Rifletto sull’estate sotto l’inverno e sull’inverno sotto l’estate, sul peso di verità taciute e di confidenze mancate. Ho un po’ di amaro in bocca, ma non so dirvi perché. Sono in treno di nuovo. Comincio un altro libro, questa volta un racconto: Il caso singolare di Benjamin Button. Assaporo la magia della lettura, che cela tra righe, lettere e parole il senso della vita. Volto la prima pagina e il gioco delle parti è ricostituito. Per ora mi basta.
* donne di malaffare

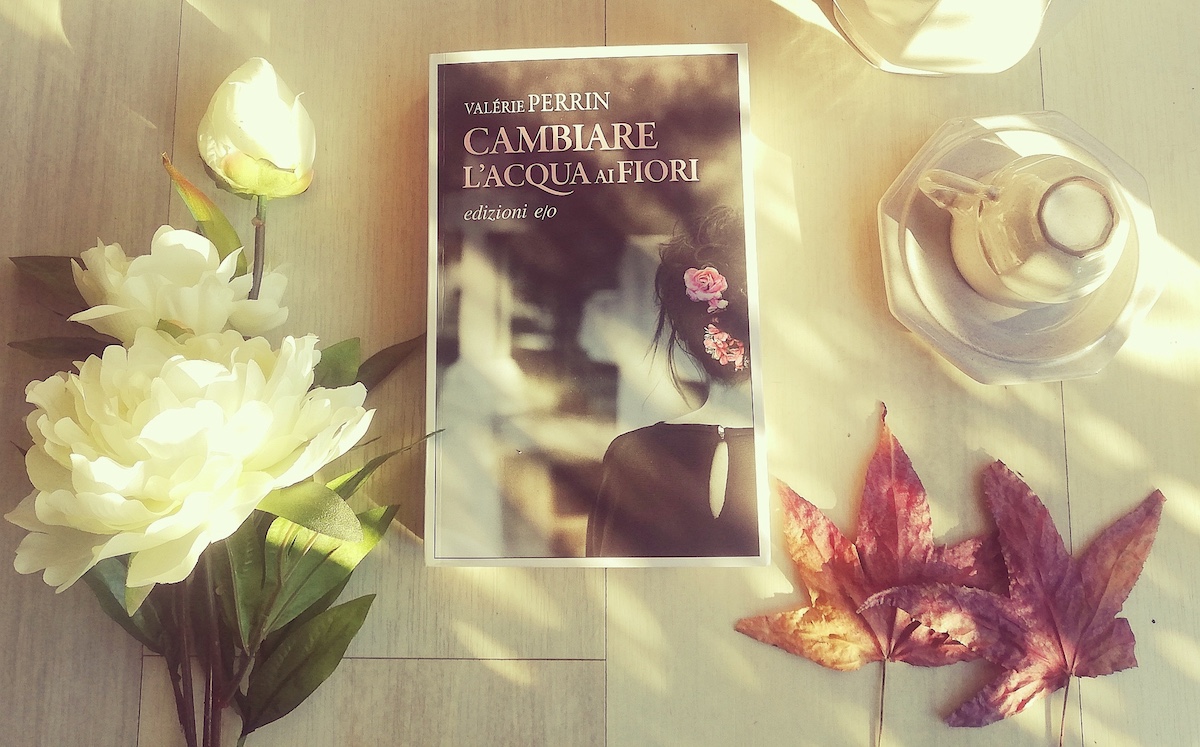



Nessun commento:
Posta un commento