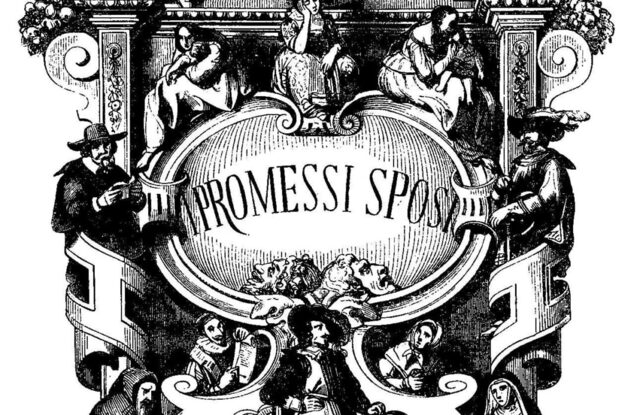Ci sono storie destinate a perdersi nei vicoli bui della memoria e del tempo… Ed altre… che incedono sicure, con sfrontatezza lungo i confini della bellezza, non inciampano, non indugiano, ti entrano nell’anima e irretiscono il cuore, mentre brividi di emozioni scorrono nelle vene, mentre fuori il mondo corre e non aspetta più nessuno… specialmente le emozioni. L’ho ripreso in mano per l’ennesima volta, non tanto per leggerne la trama, ma per mortificare, per l’ennesima volta, la mia scrittura, che mi appare rozza, troppo artefatta, un po’ “di maniera”, al confronto con la scaltrezza linguistica e l’energica sintassi di uno dei miei scrittori preferiti: lui è Franz Kafka e la sua storia è una storia di celeberrimo cambiamento, a tratti ripugnante, poco attraente per occhi poco sensibili, Metamorfosi.
6 marzo 2025
21 febbraio 2025
In treno con “Cambiare acqua ai fiori” tra sospiri, ricordi e speranze
E mentre qualcuno di voi, magari, sta già pensando di acquistarlo… rileggo e… No, non è questa la mia recensione-analisi del libro: troppo semplice, troppo sbrigativa, troppo approssimativa…
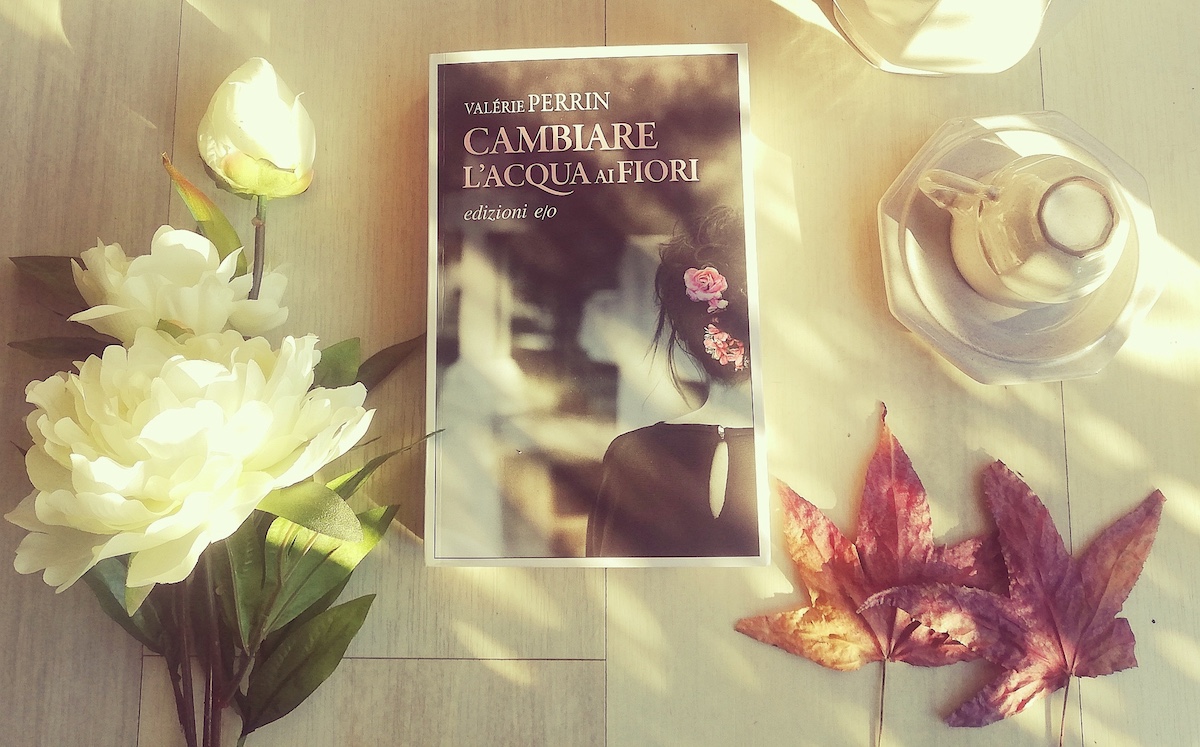

8 luglio 2024
“L’altro medioevo”: paganesimo e dualità dell’essere nella fiaba contemporanea Cavaliere senza ritorno di Ana María Matute
Cavaliere senza ritorno (La torre vigía) è un romanzo scritto nel 1971 dalla scrittrice spagnola Ana María Matute, considerato dalla critica uno dei romanzi più emblematici del genere fiabesco nel quale l’autrice ci propone una reinterpretazione delle storie di cavalleria. Come vedremo, in questo articolo si vuole dimostrare l’esistenza di un medioevo apparente, diverso da quello delle fiabe per bambini; una fiaba pagana intrisa di atmosfere sinistre.


24 giugno 2024
Quel fantascientifico di Primo Levi
Primo Levi è conosciuto al grande pubblico per essere lo scrittore di Se questo è un uomo e il reduce di Auschwitz, ma è stato anche molto altro. All’interno della sua produzione letteraria troviamo, infatti, due raccolte di racconti, Storie naturali e Vizio di forma, che possono essere accostate ai grandi nomi della letteratura fantascientifica. Sono racconti che parlano di tecnologie futuristiche, di creature fantastiche, di distopie quotidiane e, soprattutto, che narrano di vite comuni dalla quali però emergono, come smagliature nella trama, momenti di crisi nel rapporto tra l’essere umano, la natura e la tecnologia.


28 maggio 2024
Eroi e dei a confronto nella letteratura contemporanea
L’articolo tratta dell’analisi di alcune figure della mitologia classica, come Achille, Enea, il Minotauro, nei loro abiti più moderni della letteratura contemporanea. Le autrici e gli autori di cui si parlerà hanno dato un tratto differente ad ogni personaggio raccontato, aiutando così il lettore a capire più approfonditamente gli eroi e gli dei le cui storie sono state cantate dagli aedi molto tempo fa.


14 maggio 2024
"Giona o l’artista al lavoro". Creatività e fortuna nel testo di Albert Camus


19 gennaio 2024
La ricerca di Dio nel "Verbo degli uccelli" di Attar
Il Verbo degli uccelli è un poema di circa 4500 versi scritto dal poeta persiano Farīd ad-dīn ʻAṭṭār nel 1177. Quest’opera ha una grande importanza nel mondo islamico e non solo. Attraverso di essa Attar racconta l’impegno e la sofferenza necessari per affrontare il cammino iniziatico di ascesa verso la conoscenza e l’estinzione in Dio. Un po’ come nella nostra Divina commedia, anche questo poema è pieno di elementi che richiamano alla teologia ovviamente quella islamica, ma in particolare la teologia dei Sufi. Il sufismo infatti è una via spirituale non dogmatica basata sull’esigenza di un’evoluzione interiore che consenta di vivere le esperienze spirituali in maniera diretta.
_MET_DT227734.jpg/722px-%22The_Concourse_of_the_Birds%22%2C_Folio_11r_from_a_Mantiq_al-tair_(Language_of_the_Birds)_MET_DT227734.jpg)

1 gennaio 2024
Chissà? L’epilogo della pazzia nel racconto di Guy de Maupassant


19 settembre 2023
L’amore che unisce, l’amore che divide
Nella vasta opera della storia umana, l'amore è stato dipinto in un caleidoscopio di sfumature, dalla passione brevemente ardente ai legami solidi e duraturi. In effetti, dall'antica Grecia alla letteratura moderna, il concetto d’adorazione è stato esplorato in modi infiniti. Tuttavia, l’amore nella letteratura è sofferenza, struggimento, una freccia scoccata nonostante tutto, a cui non ci si può sottrarre. Com’è che questa visione si sposa perfettamente con il quotidiano che viviamo?


20 marzo 2023
Letteratura a misura di bambino
Piccolo blu e Piccolo giallo, Il mostro dei colori, Alice nel paese delle Meraviglie, Pinocchio, e si potrebbe continuare per un po’ a elencare i classici e le opere moderne che hanno fatto e fanno tuttora da sfondo alle giornate dei più piccoli e dei ragazzi e che costituiscono un bagaglio culturale di incredibile valore per la forma mentis dei primi anni di crescita.
.jpg)

24 novembre 2022
Da Desdemona a Giulietta: le vittime di Shakespeare
Desdemona, Ofelia, Fulvia, Cleopatra, Giulietta. Nomi che non hanno in comune il solo fatto di riferirsi a personaggi femminili delle opere di Shakespeare, ma anche di raccontare la storia della donna moderna. Tuttavia, la donna oggi è relativamente moderna se consideriamo che, proprio come le nostre eroine Shakespeariane, è spesso vittima di soprusi e mancanze di una società e un sistema che sono tutt'altro che moderni. Partendo dalla triste storia di Desdemona e ripercorrendo i tratti che la accomunano ad Ofelia, per poi giungere a Fulvia e Cleopatra e culminare nella amatissima Giulietta, ci ritroveremo ad identificarci perfettamente con le protagoniste, sentiremo le loro storie come se fossero nostre e avvertiremo le loro sofferenze per poi accorgerci che, in fondo, i tratti di queste donne delineati da Shakespeare più di mezzo millennio fa non sono poi così lontani da quelle che siamo noi oggi.

18 novembre 2022
Le ceneri di Pasolini
Cosa ci rimane di Pier Paolo Pasolini? Qual è il suo lascito? Il più inflazionato è certamente quello riguardante la provocazione, in tutte le sue forme, dalle più estreme alle più diafane. Quello che però sfugge ormai dalla concezione odierna che abbiamo delle sue opere, è quella di portavoce del messaggio rivoluzionario proclamato a gran voce da Gramsci: la rivoluzione intellettuale.


5 settembre 2022
Letteratura e premonizione: sulle tracce del naufragio del “Titan”
Sento ancora lo sciabordio lento e inesorabile delle algide acque. La notte nera e silenziosa si staglia sulla superficie lucida di un gigante di ghiaccio. È lui il vero titano. Ha reso ridicola la presunzione dell’uomo, rimasta irretita nelle strette maglie dell’orgoglio ferito. E tale orgoglio non può avere che un nome, destinato a diventare leggenda, condannato a mutarsi in un mito dal sapore drammaticamente doloroso: Titanic. È l’aprile del 1912. Primavera, una primavera calma, contenuta, testimone di una storia nota, che si ammanta, nel ricordo collettivo, di tragicità e segna la fine di un’età luminosa, presto ottenebrata dall’incedere mortifero della prima guerra mondiale. La Belle Epoque ha indotto alla speranza, ha illuso con il luccichio delle sue vetrine, le gonne corte e leggere, la sognante incredulità del cinematografo, i boulevard affollati. La Belle Epoque, nella sua smania di ottimismo, ha siglato la sua maestosa fama con il sigillo di una nave considerata inaffondabile, che reca nel suo stesso nome l’ambizione dei suoi costruttori: il Titanic. E’ qui che comincia la nostra storia.


21 aprile 2022
Nel mondo sospeso del Piccolo Principe


28 febbraio 2022
Padrone e cane, l’inatteso Thomas Mann


17 gennaio 2022
Nella cava di Rosso Malpelo
Nel panorama verista della Sicilia di Verga, dal buio e avito ansimare della cava di rena, Rosso Malpelo, figlio di una terra intrisa di povertà e superstizioni, è stretto nella morsa di un’esistenza dominata dalla lotta per la sopravvivenza, nato per lo spasso di un destino meschino che lo ha fatto Malpelo. Ma - scopriremo leggendo - non è l’unico vinto della novella verghiana. Non c’è spazio per i deboli, né per le emozioni. La legge del più forte e l’urgenza del bisogno sono le sole realtà possibili.


18 novembre 2021
Giovanni Pascoli e i suoi “doppi”: l'epilogo del pater-puer
Primo dicembre 1907: “Il Marzocco” pubblica il Diario autunnale. Il ticchettio del tempo incombe, come la fine ansiosa di un’estate, sul poeta prostrato dalla vita e dall’alcol, unico antidoto alla tristezza di un’anima triste. Come le caotiche facce di un cubo di Rubik, gli anni si confondono lungo una cortina di vaghezza e di ricordi, sempre sotto l’incontrastato dominio della figura paterna, immobile, attonita sotto il cielo stellato e piangente di San Lorenzo. È tornato, per l’ultima volta, lungo i sentieri della memoria. È a casa. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1907, Giovannino vuole levarsi il capriccio. Decide di passare la notte nella vecchia tenuta dei Torlonia, lì dove tutto ebbe inizio, l’incipit della fine, adesso che troppe cose sono successe. Il puer, che in quei luoghi ha smesso di essere bambino, indugia sulla porta e, nell’indefinibile incalzare dell’oscurità, tra immobilità e reazione, rivede il suo nido.


26 settembre 2021
Giovanni Pascoli e i suoi "doppi": passeggiando nel giardino della digitale purpurea (seconda parte)
È il tempo del crepuscolo. Tempo indefinito che obbedisce riverente solo alla legge della vaghezza. E di vaghezza si colorano i ricordi, come di un’alba di perla, come in una vecchia soffitta che imprigiona un vecchio album di famiglia, fatto di malinconia, polvere e sospiri. Il giardino è lì, che attende. Lui lo guarda con inevitabile sospetto: sa, per un irrazionale presagio, che la bellezza delle sue creature cela un segreto, divenuto impronunciabile, se non a patto di essere narrato attraverso il linguaggio pascoliano.


15 settembre 2021
Giovanni Pascoli e i suoi "doppi": passeggiando nel giardino della digitale purpurea (prima parte)
Quante volte si guardò nello specchio, fissando gli occhi su quel particolare del proprio volto ormai adulto: il taglio degli occhi, la palpebra leggermente abbassata, il naso lungo, la fronte alta, i baffi, un vezzo di famiglia… cercando un segno evidente della somiglianza con il padre, eredità preziosa, dono geloso.


8 agosto 2021
«I Promessi sposi»: guida all'Italia del XXI secolo
Leggere il capolavoro di Alessandro Manzoni per meglio comprendere il panorama nazionale contemporaneo